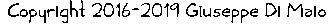Entrai
nello stanzone senza
curarmi del rumore. Era presto e sicuramente i bambini non dormivano
anche se dovevano comunque fare silenzio.
Qualcuno chiacchierava sottovoce e
solo quando scoppiavano risate a malapena soffocate i disobbedienti
venivano scoperti e
redarguiti.
Il metodo era lasciarli in pace se non esageravano: via via
si addormentavano e presto il silenzio sarebbe stato interrotto solo
dai respiri leggeri o da qualcuno che parlava nel sonno.
Elena era nel suo box protetto dalle tende bianche.
La luce sul
comodino donava una sfumatura ambrata che si estendeva per qualche
metro invadendo i primi letti. Tutti avevano l'accortezza di mettere i
bambini più tranquilli nei letti vicino al box. Le
assistenti potevano così garantirsi il tempo per un
libro,
una lettera da scrivere...
Elena aveva capelli del colore del vino nuovo e occhi che riempivano un
viso irregolare.
Era minuta; sembrava sempre sul punto di soccombere quando il vento si
alzava o quando i bambini le correvano intorno. Dal suo sguardo
però capivi che c'era una forza non comune che muoveva le
sue braccia: c'era un profondità che intuivi e che ti faceva
abbassare gli occhi quando ti guardava.
Lei non li abbassava mai e
sorrideva, forse con un filo di tristezza, ma sorrideva.
Era
il mese di
settembre,
l'ultimo turno alla Colonia per quell'anno.
Qualche giorno prima gli autobus avevano scaricato un centinaio di
bambini con la faccia spaurita e gli occhi ancora rossi di pianto.
Erano stati suddivisi in squadre ed erano in fila silenziosi e attenti
mentre gli inservienti scaricavano i bagagli e li ammassavano in un
angolo dell'immenso cortile.
La Signora Bianca, la direttrice, avrebbe tenuto il solito discorso di
benvenuto, lo stesso che avevo sentito per quattro volte e che mi
accingevo ad ascoltare per la quinta.
Non mi sarei perso nemmeno una parola: quella donna mi piaceva e mi
impauriva; era massiccia e dolce, era autoritaria e ironica, era
contemporaneamente tutto e il suo contrario. Aveva un piglio nel
gestire la Colonia che la rendeva il cuore pulsante di tutta
l'organizzazione.
Dovevo a lei l'opportunità di passare sul lago due
mesi di vacanza: ero suo ospite nonostante i miei quattordici anni.

 |
 |
 |
 |
  |
 |

Due anni
prima avevo colto
l'ultima possibilità fornita gratuitamente dal
Comune
di Milano: passai l'intero mese di luglio divertendomi e dimenticando
il travagliato anno scolastico concluso con la
bocciatura.
Ero arrabbiato
perché a scuola non mi avevano
accettato nelle poche classi di inglese e io il francese proprio non lo
sopportavo.
Avevo un gran bisogno di attenzione: il mio corpo si stava
modificando e non avevo strumenti per capire che era un passaggio
naturale.
Erano tutti
preoccupati per me.
Mi avevano addirittura mandato dallo psicologo: un signore
gentile mi aveva chiesto di illustrare la mia famiglia e io
avevo disegnato i miei genitori che tenevano per mano due bambini, un
maschio e una femmina.
Avevo dunque ucciso due delle mie tre
sorelle.
Nel disegno mio padre
era un poliziotto e aveva una pistola
mentre mia madre
sorrideva.
Cercavo di essere sempre al centro dell'attenzione, mi gratificava
anche se capivo che i
miei genitori erano disorientati e in apprensione.
Per costringere i grandi ad occuparsi di me replicavo gli
atteggiamenti provocatori e dirompenti di cui avevo
notizia. Mi avevano raccontato, per esempio, che in una terza media una
ragazza aveva
buttato in terra i libri gridando e piangendo esasperata da non so
quale problema.
Prontamente qualche giorno dopo feci esattamente lo
stesso nello stupore generale.
Mi capitava spesso di fare a botte e di tornare a casa con il naso
sanguinante oppure con gli occhiali rotti. Avevo accessi di rabbia che
mi offuscavano la vista.
Persino il prete della parrocchia fu coinvolto
nell'opera di recupero del bambino dolce e tranquillo che aveva perso
il lume della
ragione.
Durante l'ora di religione avevo infatti difeso strenuamente la mia
grande conoscenza dei meccanismi che portavano alla nascita dei
bambini. Nella totale ilarità di tutta la classe sostenevo
che i bambini venivano colti con gli ortaggi, i cavoli in particolare.
Don Roberto si informò con le mie sorelle scoprendo che
effettivamente le mie convinzioni erano il massimo della comunicazione
che avevo ricevuto.
Mi diedero quasi clandestinamente un libro che si
chiamava "Il diario di Daniele" e freddamente ancorché
scientificamente appresi che i cavoli non c'entravano nulla. Mi
vergognai tantissimo della mia ignoranza, mi vergognavo tantissimo
della mia nuova conoscenza. Mi crescevano i peli sul pube e me li
tagliavo perché non volevo che qualcuno vedesse quello che
mi stava succedendo. Un disastro insomma.
E alla fine dell'anno scolastico
fui ovviamente bocciato.
Consigliarono ai miei genitori la colonia sul lago: il clima era
ideale per calmare le esplosioni di rabbia.
Il turno di luglio era dedicato agli epilettici. Cosa c'era
di
meglio per un ragazzino spaventato dal modificarsi del suo corpo che
passare un mese con coetanei che
improvvisamente rovesciavano gli occhi e cadevano a terra in preda a
convulsioni... Un vero toccasana. C'era un bambino che viveva con un
piccolo casco che gli proteggeva la
testa: le crisi erano violente e cadendo rischiava di
ferirsi seriamente. Molti di loro dovevano prendere delle gocce quando
la crisi
iniziava e tutto il mondo si fermava quando questo accadeva. Era un
continuo scandire il tempo con le convulsioni altrui.
Per fortuna le persone che gestivano questa difficile
realtà, dalla
Signora Bianca fino all'ultima inserviente
avevano una
sensibilità e una disponibilità veramente fuori
dal comune. Anche io, con i miei piccoli problemi, finii per
beneficiare della loro umanità.
Ero in una "squadra" dove non c'erano bambini con problematiche gravi;
Alessandra, la nostra assistente, era severa e pretendeva che
rispettassimo le regole senza protestare. Ovviamente la mia situazione
era in netto contrasto con le regole.
Tendevo ad innervosirmi per ogni piccolo contrattempo e nei primi
giorni picchiai metà della mia squadra.
Alessandra cercava di tenermi a freno senza isolarmi ma con una
fermezza che probabilmente mi salvò da guai peggiori.
Riuscii a godere delle passeggiate, delle partite a calcio in un campo
vero con le porte di legno e le reti. Eravamo liberi di scorrazzare nel
parco della villa che ci ospitava tra enormi cespugli di pungitopo,
grandi alberi di
castagno e angoli nascosti dove riprovavo le emozioni della mia
infanzia.
E dimenticavo il mio corpo che cresceva.
Un pomeriggio, la passeggiata ci condusse in un campo pieno di alberi
di
mele. I frutti erano piccoli e irregolari ma erano gustosi e quando si
sparse la voce quasi tutti i bambini si arrampicarono
per cogliere le mele e mangiarle.
Gli alberi erano trattati con il verderame, un
anticrittogamico pericoloso se ingerito; di certo
non avevamo lavato le mele prima di mangiarle e nessuno ci aveva
fermato. Al nostro ritorno ci fu una grande agitazione: la Signora
Bianca si aggirava
arrabbiata per la Colonia dando ordini e disposizioni. Fummo riuniti
nel cortile e senza mezzi termini ci dissero che avevamo fatto una
stupidaggine. Il veleno dei meli poteva essere pericoloso e quindi
chiunque avesse mangiato i frutti doveva andare in sala medica e farsi
somministrare il siero anti-veleno.
Seccamente ci dissero che al primo sintomo di avvelenamento ci
avrebbero portato in ospedale e dopo
sarebbe scattata la sanzione disciplinare con l'espulsione dalla
Colonia.
Ovviamente per quelli che ammettevano la colpa non c'era solo il siero
anti-veleno: ci sarebbe stata anche una punizione non meglio definita.
Io avevo mangiato una mela ma l'idea di finire in ospedale e
poi esiliato a casa non mi sembrava male. Meglio dell'inutile
punizione. Avrei avuto l'attenzione di
molte persone e i miei sarebbero venuti addirittura da Milano solo per
me.
Dunque mi disinteressai dei medici e del siero anti-veleno.
Arrivato il
momento di andare a dormire, mi ritrovai da solo nel mio letto
nell'immensa camerata. Tutti si erano addormentati e io cominciavo ad
avere paura.
Aspettavo il mal di pancia, o uno svenimento e l'attesa del malore che
sicuramente mi avrebbe preso mi metteva agitazione, mi impediva di
dormire.
Ad un certo punto
la paura fu più forte e mi misi a piangere.
Fino a quel
momento avevo sfidato tutto e tutti senza la minima paura e quelli che
avevano osato opporsi
alle mie sfuriate si erano ritrovati a terra travolti dalla rabbia che
mi oscurava gli occhi.
Alessandra si accorse del mio pianto e mi venne vicino. Era
sorpresa o almeno così mi fece credere.
Mi chiese cosa avevo, se il male che sentivo era alla pancia o alla
testa.
Le dissi che avevo paura e che mi mancava molto la mia mamma; le
dissi anche che avevo mangiato una mela e che avrei dovuto prendere il
siero.
No, non sapevo perché mi ero rifiutato di andare in sala
medica quando era il momento, non sapevo mai il perché delle
mie azioni. Volevo solo che tutti quanti si accorgessero di me e del
dolore che provavo.
Il male che mi bruciava dentro mi annebbiava la
vista e allora
picchiavo il primo che mi capitava a tiro.
Ma i grandi mi punivano e non capivano che cosa mi stava
succedendo. Il male non passava e io avevo paura.
Fu una confessione in piena regola con le lacrime che non riuscivano a
fermarsi e i singhiozzi che mi spezzavano il respiro.
Alessandra stranamente non si
arrabbiò come mi aspettavo, mi accarezzava la testa e mi
parlava dolcemente.
Diceva che il mio era un momento di passaggio, che da bambino stavo
diventando un adolescente. Non la smetteva di accarezzarmi e mi
rassicurava. Le cose si sarebbero aggiustate.
- Lo so che ora ti sembra tutto così difficile ma vedrai che
passerà - disse. Dovevo solo cercare di calmarmi
perché ero
un bambino dolce e con la dolcezza avrei raccolto maggiori attenzioni
che con le botte. Mi accompagnò in sala medica dove mi
iniettarono qualcosa.
Tornai a letto e chiesi ad Alessandra di stare vicino a me
finché non mi fossi addormentato. Mi tenne la mano e piano
piano i singhiozzi lasciarono il campo al sonno che mi avvolse,
rassicurato da quella mano che fece quello che libri, disegni, clima e
psicologi non erano riusciti neanche ad immaginare.
Da quel giorno lei
diventò la mia migliore amica e cominciai a divertirmi con i
miei compagni ancora terrorizzati dalle botte che avevo distribuito
Alla fine del turno, tornando a casa, mi buttai piangendo tra le
braccia di
Alessandra che mi accolse e mi rassicurò
dicendomi che ero stato bravo e che non avrebbe detto nulla ai miei
genitori. Io però ero triste perché non l'avrei
più rivista e il distacco da lei era difficile e doloroso.
La
sua dolce fermezza mi aveva ridato comunque la fiducia nelle persone
adulte.
Come al solito ero diverso da tutti gli altri: i bambini
piangevano alla partenza da Milano, io piansi per il
ritorno a casa.

 |
| |